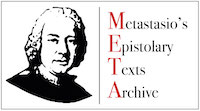llustrissimo Padrone Ranieri Calzabigi (Napoli)
Illustrissimo Signor Mio Padrone Colendissimo
30 dicembre 1747#1
Fra i molti che me ne somministra la gentilissima lettera di Vostra Signoria Illustrissima del 21 dello scorso novembre#2, non saprei se più giusto titolo di riconoscenza debba esser per me il cortese dono de’ suoi poetici componimenti se le obbliganti espressioni di stima che le accompagnano; o se l’efficace richiesta del critico mio sentimento: sento per altro assai vivamente che tutti oltre i confini del merito mio eccessivamente mi onorano. Le rendo grazie del primo a proporzione, e del piacere che già ne ho ritratto, e di quello che in avvenire replicatamente me ne prometto: non mi trattengo a bello studio#3 nelle seconde così per non compiacermene soverchiamente; anche nel ricusarle; come per non far a me stesso svantaggio, disingannandola: e mi sottrarrei ben volontieri all’adempimento dell’ultima, se avesse Ella minacciato men rigoroso castigo alla trasgressione del suo comando. Ma costretto a procurarmi il merito di così pericolosa ubbidienza#4, eccomi quale Ella mi dimanda#5.
L’argomento della sua Festa è grande, maestoso, e proporzionatissimo#6 all’occasione#7. Lo stile è felice con nobiltà, nobile senza timore, chiaro, numeroso, poetico, e tale in somma, ch’io non reputo sicurissima#8 la cura di migliorarlo#9. I pensieri#10 sono giusti, veri e connessi: e ne sarei ancora più sodisfatto, se la copia#11 loro corrispondesse alla qualità. La condotta#12 è semplice, e naturale, ma forse più del bisogno#13. Quell’ordinato, e quasi cronologico racconto de’ fatti d’Alessandro (comeché vivamente colorito#14) potrebbe addossarle l’antica taccia di Lucano#15, a cui, non per diversa cagione contrastano i severi critici il titolo di Poeta. Ma non è questo il peggior effetto che può temersi da cotesta soverchia naturalezza, osia omissione d’artificio#16. Quando destramente#17 non si propone alcun oggetto principale che stimoli, che sospenda, che determini la curiosità dello spettatore; non teme questi, non spera, non desidera, non aspetta cosa alcuna, sempre è dissipata, e vagante, e non mai riunita la sua attenzione; onde facilmente si stanca#18: siccome per l’ordinario avviene a chiunque inoltrato in incognito viaggio, non sa né quando, né dove possa sperar di fermarsi#19. E se ciò non succede#20 a’ lettori del leggiadro#21 suo drammatico componimento; tutto il merito non già alla poco artificiosa condotta#22, ma dessi attribuire interamente alla grazia, alla vivacità, et all’armonia dello stile che occupa piacevolmente e trattiene#23: né lascia alcun adito alla noia, onde possa insidiosamente insinuarsi#24. Pur se vuol Ella sensibilmente convincersi che cotesta soverchia semplicità sia poco atta ad inspirar quella inquieta sospension d’animo#25 che rapisca a forza l’altrui attenzione; finga per un momento di terminare alla ventura il suo dramma in qualunque parte di esso: et osservi che dovunque le sarà occorso di terminarlo, lascerà sempre i lettori indifferentemente tranquilli#26 .
La canzonetta#27, come specie di componimento, di cui più dipende il valore dai vezzi dello stile, che dall’artificio della condotta; non si risente della mancanza di questa; et ostenta i pregi dell’altro#28. È piena di pensieri, e delicatamente concepiti, e gentilmente prodotti: onde e di questa e del Sogno d’Olimpia mi congratulo sinceramente seco#29: assicurandola, con quel candore, (di cui forse in questa lettera le ho data eccedente prova) che da lungo tempo in qua non mi son pervenute d’Italia composizioni poetiche che tanto m’abbiano sodisfatto: e che io giudico su tali fondamenti non esser questi i più alti segni a’ quali possono aspirare i suoi felici talenti.
Non abbiamo, a dir vero, alcun canone poetico che ci obblighi indispensabilmente a far uso delle comparazioni#30: ma è cosa per altro assai degna d’osservazione che in un considerabil numero di versi non gliene sia scorsa della penna né pure inavvedutamente qualcuna. Se forse la copia stucchevole delle medesime con cui ci perseguitano gl’inetti scrittori, le ha private della sua grazia; torni a rappattumarsi#31 con esse. Sono queste gli stromenti più atti a rendere amene, e sensibili l’idee più severe, et astratte; han fatto sempre una gran parte fin ora della sacra, e della profana eloquenza: e di nessuna dovremmo più dilettarci, se l’abuso che ne fanno i cattivi artefici, fosse bastante ragione per aborrir le bell’arti#32.
Gradisca la mia ubbidienza: accetti in contraccambio della gentile offerta della sua amicizia, la sincera servitù mia: e permetta ch’io cominci ad esercitarla protestandomi
Di Vostra Signoria Illustrissima
Vienna 30 Xbre 1747 Umilissimo et Obbligatissimo Servitore
Pietro Metastasio
La data erronea riportata dal testimone B (copialettere A), «a Napoli da Vienna 30 Gen° 1748» (con 20 corretto in 30), è da correggersi con quella autografa qui adottata, come già segnalato in Brunelli (Lettere, III, p. 1222, nota 2 alla lettera n. 271), sulla scorta di Antona Traversi: cfr. le già citate Lettere disperse e inedite di Pietro Metastasio, in particolare la nota 1 a p. 14: «L'ediz. di Vienna, e quella di Napoli, hanno, erroneamente, questa data: Vienna li 30 gennajo 1748. – La lettera fu anche riprodotta, con questa falsa data, in più edizioni delle Opere del Metastasio. Citiamo, ad esempio, quella di Firenze {Vol. unico – Felice Le Monnier e Compagni} del 1838 (pagg. 917-918)». Si veda la riproduzione dell’edizione sul sito «HathiTrust Digital Library», [Online], consultato il 10 agosto 2023, URL: https://www.hathitrust.org/.
eccomi … dimanda: conclusasi la sezione introduttiva trapuntata dei consueti convenevoli, si apre ora la parte più intensa, almeno sotto il profilo critico-letterario, della responsiva metastasiana. Il lettore noterà nella presentazione delle diverse questioni un andamento apparentemente ‘ondulatorio’, per il quale momenti di lodi si alternano con sapienza ed equilibrio a esplicite cassature di natura metodologica. Le voci di cortesia che sembrano voler ritmare i giudizi di Metastasio stemperano perciò soltanto temporaneamente e superficialmente il giudizio di fondo, che resta censorio.
all’occasione: come si anticipava nell’Introduzione, la festa teatrale in oggetto è Il sogno di Olimpia, che fu rappresentata a Napoli nel novembre 1747, come recita la sua intestazione: «Il sogno d’Olimpia festa teatrale per musica da rappresentarsi Nel Teatro della Gran Sala del Real Palazzo, e nel Real Teatro di S. Carlo per festeggiare la nascita Del Real Principe delle due Sicilie Filippo Di Borbone Ne’ giorni 6. 11. 13. 16. del mese di Novembre 1747, in Napoli MDCCXLVII, Per il Ricciardi Stampatore del Real Palazzo» (cfr. la scheda a cura dell’Università di Padova sul sito «Libretti d’opera», [Online], consultato il 10 agosto 2023. URL: https://www.librettodopera.it/public/. Si veda inoltre la Narrazione delle solenni reali feste fatte celebrare in Napoli da Sua Maestà il Re delle due Sicilie Carlo Infante di Spagna duca di Parma, Piacenza &c. &c. per la nascita del suo primogenito Filippo Real Principe delle due Sicilie, Napoli [ma Roma], MDCCXXXXVIIII, in particolare il passo alle pp. 8-9. Si considerino le tavole v («Sala del Palazzo Reale apparata per la Serenata») e vi («Disegno della Scena, che servì per la Serenata nel Real Teatro di S. Carlo rappresentante una Deliciosa [scilicet la scena], che introduce ad un magnifico Tempio Domestico nella Reggia di Macedonia»). Se si presta fede al cronogramma qui riportato, la data dell’11 novembre sarà forse da correggersi in 12: cfr. ivi, p. 4: «[…] Sabato 11. Mezza Gala, Festa di Ballo in dominò, e Giuoco in Palazzo. / Domenica 12. Mezza Gala, e Serenata al Teatro». Essendo le date della rappresentazione indicate nel libretto antecedenti a quelle della prima missiva calzabigiana (21 novembre), è altamente probabile che Calzabigi avesse sottoposto a Metastasio il testo del proprio dramma stampato in occasione delle rappresentazioni napoletane. Come già segnalato in Tufano, I viaggi di Orfeo, i, Il primo soggiorno napoletano: documenti e ipotesi, pp. 1-17, in particolare p. 13, nota 43, un’attestazione dell’effettiva circolazione del libretto di Calzabigi nel periodo in oggetto è testimoniata da una lettera del politico, giurista e fiduciario del re di Napoli Bernardo Tanucci (1698-1783) datata da Napoli, 28 novembre 1747 e indirizzata all’amico Francesco Nefetti: «Non è fatta la stampa delle nostre feste, e forse non si farà. È stampata la serenata di Calsabigia, ma la mole non è involto epistolare [...]»: cfr. Bernardo Tanucci, Epistolario, a cura di Romano Paolo Coppini e Rolando Nieri, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1980, n. 230, pp. 333-334.
sicurissima: ‘necessaria’.
felice … migliorarlo: la poesia di questo libretto è improntata a quell’ideale di naturalezza su cui Metastasio ritorna più attentamente in séguito: periodi brevi in paratassi, uso di asindeti, stile dal registro tendenzialmente elevato ma mai eccessivamente ricercato, parco impiego di figure retoriche (coppie di aggettivi esornativi, chiasmi, rime interne, anafore, anadiplosi, allitterazioni e altri calcolati effetti fonici).
pensieri: l’insieme delle idee e dei contenuti che precedono la dispositio del materiale nell’organismo del melodramma.
copia: ‘abbondanza, ricchezza’, lat.
condotta: tecnicismo drammaturgico con cui si indica la tessitura della favola teatrale, come specificherà Calzabigi alcuni anni dopo nell’encomiastica Dissertazione, presumibilmente anche sulla scia delle suggestioni metastasiane, pp. 68-69.
ma forse più del bisogno: l’esilità e la linearità dello sviluppo della materia del Sogno d’Olimpia è uno dei primi argomenti su cui Metastasio, autore di libretti caratterizzati da una più costruita complessità e da una pressoché costante duplicità di intreccio, manifesta il suo disappunto.
colorito: ‘brioso, vivace’. Metastasio allude allo sciorinamento delle imprese alessandrine che a voci alterne le divinità di Apollo, Marte e Giove illustrano a Olimpia, assunta durante il sonno in cielo al loro cospetto: cfr. Il Sogno d’Olimpia, pp. 25-34.
l’antica taccia di Lucano: cioè l’essere più uno storico che un poeta. Sul rischio di deformare il dramma in una mera restituzione narrativa e di privare così il suo argomento dell’essenziale elaborazione drammaturgica si era già espresso il maestro di Metastasio, Gian Vincenzo Gravina, nel suo trattato Della tragedia, sentenziando «si narra per rappresentare, non si rappresenta per narrare». Cfr. su questo argomento CARUSO, Metastasio e il dramma antico, pp. 167-170. Il punto in oggetto era già stato osservato da FRANCESCA MENCHELLI-BUTTINI, Due feste teatrali napoletane di Ranieri de’ Calzabigi, in Ranieri Calzabigi tra Vienna e Napoli, Atti del Convegno di Studi, (Livorno, 23-24 settembre 1996), a cura di Federico Marri e Francesco Paolo Russo, Lucca, LIM, 1998, pp. 147-163, in particolare p. 153. Si deve al contempo tenere presente anche la contezza dei dettami della precettistica oraziana, agli studiosi di teatro ovviamente sempre ben presenti, e a Metastasio traduttore dell’Ars poetica in particolare: cfr. Tutte le opere, vol. II, p. 1234: «D’un’azione ogni parte o su la scena / Si rappresenta, o si racconta […]». Cfr. infine quanto Metastasio sostiene nel cap. XV dell’Estratto, pp. 126-129.
soverchia naturalezza, osia omissione d’artificio: in questo dato risiede uno degli aspetti fondamentali in cui si misura la differenza tra la cosiddetta “riforma metastasiana” e quella “calzabigiana”: come si è già accennato, se il già riformato Metastasio ha il merito di rinnovare in senso razionalistico le forme del melodramma (ma per certi versi risente ancora degli influssi di una temperie tardo-barocca), Calzabigi si fa sicuro assertore di un’estremizzazione di quello stesso rinnovamento.
destramente: l’avverbio pare colorarsi di un’accezione velenosamente ironica.
non si propone … si stanca: altra stoccata piuttosto tagliente, che contiene in fondo un’accusa abbastanza grave: per Metastasio, la prova melodrammatica in oggetto manca di un ingrediente fondamentale, ossia la presenza di un soggetto o un’azione principale capace di stimolare e mantenere viva l’attenzione e l’aspettativa degli spettatori, evitando di suscitare in loro noia e delusione.
siccome … fermarsi: a beneficio di quanto Metastasio sta per osservare nell’ultimo paragrafo della lettera, si noti che l’immagine metaforica dei viaggiatori erranti-vagabondi è un’autentica «comparazione».
se ciò non succede: fingendo di negare che l’opera sia noiosa, Metastasio vuole in realtà insinuare proprio che lo sia.
leggiadro: il sapore di questo aggettivo, a giudicare dal tono che va assumendo il contesto, non può che risultare ironico, cortese ma sminuente.
poco artificiosa condotta: Metastasio non si risparmia dall’insistere sul carattere eccessivamente scarno e lineare della «condotta» del Sogno.
alla grazia … trattiene: sotto le false sembianze di un complimentoso tricolon, Metastasio continua la scomoda ma implacabile esposizione delle sue riserve: egli lascia infatti intendere che, in realtà, se gli spettatori del Sogno non hanno provato alcuna noia, ciò è stato reso possibile semplicemente dal fatto che essi siano stati ‘distratti’ dalle qualità dalla veste poetica del componimento: insomma, in assenza di una convincente argomentazione ed elaborazione contenutistico-drammaturgica e di intrinseche virtù melodrammatiche, almeno la forma può aver avuto il merito di aver evitato un fallimento della rappresentazione sotto tutti i punti di vista.
Ma non è questo … insidiosamente insinuarsi: sugli importanti aspetti di questo nodo dell’epistola cfr. l'introduzione al volume cartaceo del carteggio, par. 2.
quella inquieta sospension d’animo: componente che Metastasio ritiene indispensabile per una corretta edificazione della favola teatrale. Si veda nuovamente, a tal proposito, quanto Calzabigi in un’ottica di celebrazione metastasiana, ripeterà nella Dissertazione, p. 69.
tranquilli: aggettivo più gentile e affettato del corrispettivo equivalente ‘indifferenti’. Cfr. sul tema quanto scritto nel commento alla traduzione dell’Ars oraziana, in Tutte le opere, vol. II, p. 1265 (commento al v. 148): «Orazio […] insegna […] che per tener sospeso ed attento il lettore, o spettatore, è necessario che il corso delle favole mai non s’arresti, e mostri sempre d’avvicinarsi alla catastrofe. Le narrazioni, le descrizioni, gli episodii, le dispute quasi accademiche, le ricercate e numerose sentenze, non necessarie all’azione, quantunque degne per se medesime d’ammirazione e di lode, fermano il corso della favola, allontanano la catastrofe, e fanno cangiare in tedio la delusa curiosità dello spettatore».
canzonetta: non è dato sapere di quale testo si tratti, non essendo pervenuta la missiva di Calzabigi.
non si risente … dell’altro: l’anonima «canzonetta» è tacciata della medesima macchia del già rimproverato Sogno: una generale ma non trascurabile assenza di sorveglianza della citata «condotta», bilanciata dalla levigatezza di uno stile meglio meditato.
di questa … seco: terminata l’esposizione delle critiche, Metastasio interpone un forse non insincero apprezzamento nei confronti delle soluzioni poetico-stilistiche di Calzabigi, un garbato apprezzamento che stempera soltanto parzialmente la bocciatura che sottende l’intera epistola.
comparazioni: per il tema si rinvia ancora all’Introduzione al volume cartaceo del carteggio, par. 2.
rappattumarsi: ‘riconciliarsi’. Anche l’immagine della caduta in disgrazia delle comparazioni presso Calzabigi e quella della ritrovata armonia tra il poeta e gli attrezzi del suo laboratorio sono in fondo provocatorie figure retoriche.
gli stromenti … bell’arti: nello spiegare il motivo del loro impiego Metastasio espone una sorta di dichiarazione poetica.
30 dicembre 1747] Al Signor Ranieri Calzabigi. a Napoli da Vienna 20 Gennaio 1748 con correzione del nome Aluigi in Ranieri B
che me ne] che mi C
esser per me il cortese dono de’ suoi poetici componimenti] esser il cortese dono de’ suoi poetici componimenti per me C
tutti] tutte B C
soverchiamente] sovverchiamente B C
far] fare B C
volontieri] volentieri B
avesse Ella] ella avesse B C
comando] commando C
pericolosa] pericoloso B
dimanda] domanda C
nobile] e nobile con e aggiunta dalla mano del revisore B
timore] tumore A B C
migliorarlo] megliorarlo C
Lucano] Lucano sottolineato C
non] aggiunto in interlinea B
cagione] ragione B C
contrastano i severi] contrastano · severi C
soverchia] sovverchia B C
artificio] artifizio B
sospenda] sospennda C
non spera, non desidera, non aspetta cosa alcuna] non spera, non desidera cosa alcuna C
poco] poca C
trattiene] tratiene C
né] e corretto in ne C
soverchia] sovverchia C
quella] quella cassato e corretto in interlinea in la necessaria B la necessaria C
sospension d’animo che rapisca a forza l’altrui attenzione; finga per un momento di] sospensione; finga pure (pure cassato) per un momento (momento cassato e riscritto) di B sospensione; finga che per un momento di C
di esso] d’esso B C
più dipende il valore] dipende più il calore con più aggiunto in interlinea C
artificio] artifizio B C
pregi] pregi corretto in preggj C
e delicatamente] delicatamente B C
onde e di] onde di B C
ho] è corretta in ò B
eccedente prova] evidente pruova B C
che io] ch’io C
non] aggiunta in interlinea B
alcun] nissun cassato e sostituito da alcun B
comparazioni] comparazioni cassato e riscritto B
della] per la corretto in della B della corretto in dalla C
stucchevole] aggiunta di altra mano in uno spazio lasciato vuoto B
queste] questi B
astratte] riscritto su astratto B
nessuna] nessuna corretto in nissuna C
accetti] et accetti B C
contraccambio] contracambio B C
e permetta] e permetta cassato, permettendomi aggiunto in interlinea B permettendomi C
e di nessuna … Illustrissima] aggiunta di altra mano B