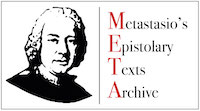Al Signor de Calzabigi da Vienna. a Parigi 14 Febbraro 1755.
Era già io con la penna alla mano per dimandarvi ragione del vostro silenzio: stimolato non solo dalla mia, ma dall’impazienza altresì di molti, a’ quali sulla vostra fede io ho promessa la pubblicazione della ristampa parigina degli scritti miei per l’ingresso del corrente anno; quando mi fu#1 recata la gratissima vostra del 10 dello scorso gennaio. Ho difesa la dilazione, e confermate le speranze per il mese d’aprile: e se lo spaccio corrispondesse poi alle presenti istanze, qui si dovrebbe aspettare considerabile#2: ma voi sapete che molte di queste ricerche sono incensi cortesi all’autore, molte altre ripieghi passeggeri per riempire il vuoto di qualche cadente conversazione: e molte in fine suggestioni della comun vanità d’esser compreso nel numero delle persone di buon gusto. Tutti fenomeni che per lo più si dileguano a fronte della spesa#3. Onde bisogna fidarsene discretamente. Mi piace l’ordine de’ componimenti nella ristampa#4: ma mi sarebbe piaciuto assai più che voi aveste fusi e mescolati, non così semplicemente inseriti nella bellissima vostra dissertazione i miei dettami intorno all’unità del loco, e dell’antico coro. Mi prometto per altro che l’avrete fatto con tal destrezza che il lavoro non comparirà intarsiato#5.
Assicurate di tutta la dovuta mia riconoscenza il signor Gerbault#6 per il cortese dono del Marchetti che mi prepara: e promettete ch’io farò l’uso migliore che per me si possa de’ programmi#7 dell’Ariosto che disegna inviarmi#8. Ma in quanto alla destinazione delle dediche de’ rami#9, io abbisogno di più minuta istruzione per servirlo con utilità. Se egli non si propone che il decoro della sua edizione nell’adornarla de’ nomi delle persone più distinte del secolo; io potrò suggerirgli quelle che risplendono in questo emisfero: ma se egli uccellasse per avventura a’ Mecenati; io sono il più ignorante di tutti i cacciatori#10, e lo consiglio da buon cristiano di valersi di qualche meno inetto commissario.
Vi compatisco caro amico, e vi ammiro per la dedica#11 alla quale vi siete trovato obbligato. Io confesso che quelle strettoie#12 non avrebbero lasciata alle mie muse la leggiadra disinvoltura che han conservata le vostre#13. Voi non mi domandate consiglio#14: onde il darvene è temerità: ma io credo tradimento il tacervi le mie osservazioni: onde soffritemi con quel difetto che vi assicura della mia vera amicizia.
La forma#15 del componimento che avete scelta non può ridursi che alla categoria delle cantate a voce sola. Or una cantata di questa specie con quattro ariette, non si può eseguire: perché non v’è musico d’organo così instancabile, che possa cantar senza interruzione quattro ariette, e tanto recitativo: et una cantata che non può cantarsi, non è men reprensibile d’una tragedia che non possa essere rappresentata#16. Se ne toglieste la prima, e la terza arietta: e restringeste l’ultimo recitativo, il componimento avrebbe la sua regolare estensione#17. Gli resta appena ardire di fissar voi. Credo che convenga dire di fissarsi in voi. Altrimenti significa fermarvi#18. Come si dice del mercurio#19. In que’ sguardi confusi bisogna dire in quegli secondo i pedanti#20, e questi che non sanno altra cosa, non ci perdonano il delitto di poter fare ciocché essi non ponno. Voi vedete che son tutti nei da mandar via, come si suol dire, con l’acqua benedetta#21, et io quando posso sfuggo di far gracchiare i ranocchi#22. Io ho esperienza della vostra maniera di pensare, e perciò m’avventuro a tanta confidenza#23: rendetemene il meritato contraccambio, quando ne trovate il bisogno: e frattanto conservatevi, riamatemi, comandatemi, e credetemi.
Il vostro etc.
bellissima vostra] vostra bellissima A
che … rappresentata] che non possa esser recitata con recitata cassato e corretto in rappresentata A
ciocché] ciòcche con integrazione della seconda c ad opera della mano del revisore A